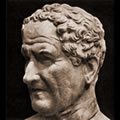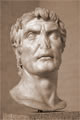I Gracchi.
I Gracchi.
Un periodo di grande sconvolgimento fu l’età graccana, che
fu descritta da Diodoro, Appiano e Plutarco. Uno dei più importanti
motivi di crisi della Roma di questo periodo consiste nell’espropriazione
dei piccoli proprietari terrieri, cui aveva fatto seguito lo spopolamento
delle campagne e la crisi demografica. La famiglia dei Gracchi
si
fa interprete delle istanze della plebe che più di chiunque
scontava le conseguenze di tale crisi.
Nel 133
Tiberio Gracco, figlio di Tiberio Sempronio Gracco,
viene eletto tribuno e presenta una legge sulla misura dell’agro
pubblico secondo la quale quest’ultimo doveva essere diviso in lotti
non superiori a 500 iugeri. Chi ne possedeva di più doveva restituirli
affinché una commissione (detta “
dei tresviri”)
procedesse all’assegnazione a favore della plebe nullatenente. Il
tribuno Ottavio oppose il proprio veto. Tiberio, non riuscendo a far togliere
il veto,
fece
deporre Ottavio dall’Assemblea.
La legge viene quindi approvata ma la sua attuazione incontra mille difficoltà
opposte per far terminare
 |
I Gracchi |
l’anno di carica di Tiberio che tuttavia,
al termine del mandato,
ripropone
la sua candidatura. Questo fa scoppiare dei disordini in cui
Tiberio trova la morte. A questo punto dovranno trascorrere dieci anni prima del
secondo tribunato graccano.
Caio Gracco (123) si preoccupò di garantire una
funzione costituzionale alla neonata
ordo degli
equites
proponendo una legge sul trasferimento delle corti giudicanti dai Senatori
ai cavalieri, assicurando così a quest’ultimi il compito
di giudicare nelle
quaestiones extra ordinem. Propose inoltre
numerosissime altre leggi, tra le quali:
- provvedimenti per la fondazione di nuove colonie;
- legge sull’attribuzione delle sfere di competenza ai singoli consoli;
- legge sull’organizzazione della provincia d’Asia;
- legge che proponeva di concedere la cittadinanza romana ai latini e
quella latina agli Italici;
- legge “de repetundis”, l’unica rimastaci
in materia criminale.
L’esperienza graccana si protrasse per i due tribunati del 123 e
122. Dopo i tentativi di far abrogare la
lex Rubria, il Senato
votò un provvedimento senza precedenti, il
senatus consultum
ultimum, che aboliva le garanzie costituzionali e dava ordine al
console
Lucio Opimio di operare la repressione dei tumulti.
Roma fu occupata militarmente e i graccani, ritiratisi sull’Aventino,
furono in gran parte uccisi, compreso Caio. La morte di Caio segna l’inizio
effettivo delle guerre civili.
 Mario e Silla.
Mario e Silla.
Dopo la repressione graccana si assiste alla formazione della
factio
in seno alla
nobilitas, un gruppo ristretto della classe dirigente
che accentra tutte le magistrature e le posizioni di
governo. I poteri
dei tresviri vengono ridotti da tre leggi:
- una legge del 121 che abolisce il divieto di alienazione dei terreni distribuiti;
- la lex Toria del 111 che sancisce la definitività
del possesso dell’ager publicus;
- una legge del 111 con cui si abolisce il vectigal.
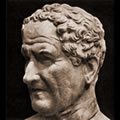 |
Mario |
Nel 106
Servilio Cepione reintroduce i Senatori nella
quaestio de repetundis, la cui giuria deve essere quindi composta
per metà da Senatori e per metà da cavalieri.
In seguito alla guerra di Numidia e all’ascesa al trono di
Giugurta
(figlio illegittimo del re di Numidia ma appoggiato da Roma), si creano
in Roma due fazioni, una interventista – guidata dai cavalieri –
e una non interventista – guidata dal Senato. Una strage di mercanti
romani operata da Giugurta a Cirta fa scoppiare la guerra.
Caio
Mario – successo al comando delle operazioni in Numidia
a
Quinto Cecilio Metello – riesce a catturare Giugurta
grazie anche all’aiuto del suo luogotenente
Silla.
Contemporaneamente alla guerra in Numidia, le popolazioni barbare dei
Cimbri e dei Teutoni invadono l’Italia settentrionale infliggendo
una pesante sconfitta ai romani. Mario – che era stato eletto console
– vide prolungato il suo mandato dal 104 al 101, anno in cui sconfisse
gli invasori. Le gravi perdite di quegli anni indussero Mario ad
arruolare anche la plebe urbana non iscritta nelle centurie e gli italici.
Nel 100 Mario si ripresenta al Consolato, alleandosi con
Apuleio
Saturnino e con
Servio Glaucia. A questi
ultimi si dovettero:
- la lex Apuleia de maiestate minuta che ampliava l’ambito
dei delitti politici;
- la lex frumentaria che abbassava il prezzo del grano;
- la lex agraria che distribuiva ai veterani l’ager
gallicus conquistato da Mario;
- una lex de coloniis in Africam deducendis per distribuire
100 iugeri a testa tra i veterani in Numidia.
Durante i comizi elettorali
Gaio Memmio, candidato avverso
a Glaucia, viene ucciso in un tumulto: il Senato vota quindi un
senatus
consultum ultimum e ordina a Mario di attaccare Apuleio, Glaucia
e i loro seguaci. Mario, consapevole che ciò avrebbe compromesso
il suo credito e il suo potere politico, esegue suo malgrado l’ordine.
Le leggi di Apuleio e Glaucia saranno abrogate e sarà così
stroncato il secondo tentativo di cambiamento.
Riguardo al
senatus consultum ultimum, molti studiosi romanisti
affermano che il Senato compì un abuso, ma non considerano che
presso gli antichi non esisteva una costituzioni scritta ma solo una prassi
costituzionale determinata da rapporti di forza.
La
quaestio de maiestate è la seconda quaestio perpetua
dopo quella
de repetundis, ma al contrario di quest’ultima
è attivata per conto dello Stato, e l’accusa viene esercitata
solo da cittadini romani.
La produzione normativa di questo periodo è molto vasta e si sente
il bisogno di proteggerla: nasce così la
sanctio legis
di Saturnino la clausola propria delle leggi che si prevede saranno fortemente
osteggiate dagli oligarchici.
Nel 92, il tribuno
Livio Druso propose che il numero
dei Senatori fosse raddoppiato e che i nuovi Senatori fossero
equites.
Tale misura era di carattere conciliativo: si sarebbe così arginato
lo strapotere degli
equites con l’immissione nel Senato
dei membri più influenti e sarebbe terminata la lacerante contesa
per il controllo delle
quaestiones
perpetue. In campo popolare Druso concesse la cittadinanza agli
italici per porre rimedio alla loro contrarietà alla distribuzione
delle terre.
La morte di Druso lasciò aperta una situazione di estrema tensione
che sfocerà nel 90 nella guerra sociale. In tale anno insorgeranno
contro Roma tutti gli alleati italici che creeranno una vera e propria
“
civitas Italia” contrapposta alla “
civitas
romana” con una propria organizzazione indipendente. La guerra
sarà sanguinosissima (oltre 300.000 caduti per parte) e terminerà
con l’emanazione di tre leggi:
- la lex Iulia del 90 che concede la cittadinanza romana
a tutti gli italici che non avessero preso le armi contro Roma;
- la lex Plautia Papiria dell’89 che concede la cittadinanza
romana a tutti gli italici che ne facciano richiesta;
- la lex Pompeia dell’88 che concede lo ius Latii
agli abitanti della Gallia Cisalpina.
Nonostante l’estensione della cittadinanza, il modello romano non
cambia: tutte le città d’Italia diventano municipi “
optimo
iure”.
Intanto nell’88 scoppia la guerra contro
Mitridate
re del Ponto. Il tribuno
Sulpicio Rufo propose due leggi,
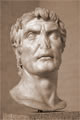 |
Silla |
una delle quali toglieva il comando delle operazioni di guerra a Silla
– che aveva già radunato il suo esercito a Napoli –
e l’altra che iscriveva gli italici in tutte le 35 tribù.
Silla – che sarebbe stato sostituito da Mario – marciò
su Roma, cacciò Mario e fece abrogare le leggi di Sulpicio; dopodiché
partì per la guerra.
Mentre Silla vinceva Mitridate a Cheronea e a Orcomeno,
Cinna
– eletto console nell’87 – instaurò a Roma, per
tre anni, un potere dispotico e antinobiliare: nacquero le liste di proscrizione.
Silla, conclusa la pace con Mitridate, tornò in Italia nell’83
e sconfisse i cinnati nella battaglia di Porta Collina dell’82.
Roma vive ora uno dei momenti più drammatici della sua storia:
le proscrizioni hanno ridotto il Senato da 300 a 100 membri; 100.000 veterani
di Silla chiedono terre, e Silla concede loro di occupare le terre italiche
dove vogliano all’interno di determinati confini.
Silla ebbe dopo l’82 una
formale investitura perpetua a dittatore
per la riorganizzazione dello Stato. Il Senato fu portato a 600 membri,
e i nuovi Senatori furono in massima parte
equites, forse scelti
direttamente da Silla. La
lex Villia “
de annalis”
del 180 ripristinò gli intervalli regolari tra le magistrature.
Una legge permise ai soli Senatori di rivestire il tribunato e vietò
a chi era stato tribuno di rivestire cariche successive. Con Silla le
quaestiones perpetue divennero 6 o 7 (o addirittura 9). Si conoscono:
- la quaestio perpetua peculatos, che si occupa della repressione
del peculato;
- la quaestio de ambitu, che si occupa della repressione
delle frodi elettorali;
- la quaestio de falsis, che si occupa dei reati di falsificazione;
- la quaestio testamentaria nummaria, che si occupa delle
falsificazioni di testamenti e monete;
- la quaestio de sicariis et veneficiis, che è una
quaestio plurima che si occupa di reati vari.
Con le
quaestiones scompare il potere giudiziario delle assemblee
popolari e conseguentemente dei tribuni, che dinanzi ad esse portavano
l’accusa.
Ogni
quaestio era attivata da un’accusa che un cittadino
portava avanti dopo una richiesta a un giudice che valutava il fondamento
dell’accusa. In antichità un fatto non poteva essere sottoposto
due volte al giudizio dello stesso organo: ciò favoriva la
prevaricatio,
la collusione fra accusato e accusatore. Silla spogliò infine il
tribunato di ogni potere: la
lex Hortensia fu abrogata e fu ripristinata
la
lex Publilia Filonis.
Gli storici antichi non hanno mai parlato di “costituzione sillana”,
ma solo di Silla come uomo e riformatore. Per quanto riguarda la storiografia
moderna, il Carcopino dice che Silla segnò l’inizio di un
potere monarchico; altri parlano di Silla come restauratore. In realtà
egli fu un riformatore in chiave oligarchica e antipopolare.